
di quanto vale quando comincia a mancare.”
Piero Calamandrei
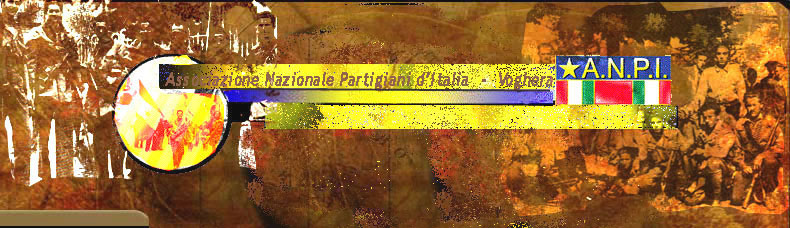
 Carlo Pisacane: Il patriota che diede il
Carlo Pisacane: Il patriota che diede il
nome ad una brigata partigiana dell’Oltrepo
La sezione ANPI di Voghera, come contributo alle celebrazioni per il 150º anniversario
dell’Unità d’Italia, rievoca la storia di vita e di passioni ideali di Carlo Pisacane,
il patriota, rivoluzionario e letterato italiano risorgimentale, che diede il nome ad
una delle brigate partigiane che combattè nell’Oltrepo pavese nelle fila della
Divisione garibaldina "Aliotta".
 Carlo Pisacane nacque a Napoli il
Carlo Pisacane nacque a Napoli il
22 Agosto 1818, figlio della nobile
famiglia dei duchi di San Govanni.
A 14 anni intraprese la carriera
militare entrando nel collegio militare
della "Nunziatella".Nel 1843 venne
promosso tenente. A causa degli
eventi negativi e delle pressioni che
seguirono la sua relazione con una
giovane donna sposata, nel 1847
abbandonò la carriera militare (gesto
di ribellione che indicava la sua
insofferenza per il conformismo degli
ambienti militari e della società
borbonica) e si stabilì, con la sua
amata (Enrichetta De Lorenzo),
prima a Livorno poi Marsiglia,
Londra e Parigi (inseguiti e
perseguitati, nei loro spostamenti
dalla polizia napoletana).
In seguito si arruolò
nella "legione straniera" francese e, con il grado di sottotenente, fu
fu impegnato in Algeria contro gli uomini dell’emiro Abd-el-Kader.
Venuto a conoscenza dei "moti di Milano" del 1848 si congedò dalla "legione" e si diresse nel
capoluogo lombardo, che raggiunse il 14 Aprile, e combattè, nell’ultima fase della prima guerra
d’indipendenza, criticando aspramente la diffidenza di Carlo Alberto verso i volontari,
(che indicò, nel suo scritto "sul momentaneo ordinamento dell’esercito lombardo in aprile 1848"
quale importante espressione di una lotta popolare), ed inoltre la lentezza e le indecisioni
dell’esercito sabaudo.
La disfatta di quell’esperienza ( fu anche ferito al braccio destro il 25 giugno) non lo scoraggiò,
anzi si rafforzò nel suo pensiero la concezione del carattere della guerra popolare.
Nel 1949 insieme a Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, è uno degli artefici della difesa
della Repubblica Romana. Nominato membro della commisssione di Guerra ed in seguito capo
di stato maggiore dell’esercito romano,
difese strenuamente la Repubblica dai francesi, chiamati
da Papa Pio IX. Nonostante essa ebbe vita breve (5 mesi, dal 9 febbraio al 4 luglio) l’esperienza
capitolina fu significativa nella storia dell’unificazione italiana e
Carlo Pisacane, che organizzò un
esercito di volontari arrivati da tutta Italia, riuscì anche a cogliere dei significativi successi, come
la vittoria del 30 Aprile contro le truppe di Napoleone III.
Il 3 luglio 1849 venne arrestato e imprigionato in Castel Sant’Angelo. Liberato poco dopo,
grazie all’intervento della moglie (Enrichetta si prodigò durante la Repubblica Romana come
infermiera), partì esule per Marsiglia, poi per Losanna ed infine
approdò a Londra.
È di questo periodo lo scritto "Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49" dove polemizzava
sia con Garibaldi (a cui imputatava velleità dittatoriali) sia con Mazzini accusato di formalismo,
cioè a tendere ad un cambiamento formale e non sostanziale del governo e delle basi della
società.
Carlo Pisacane pensava che se la nuova rivoluzione italiana non fosse stata anche una
rivoluzione sociale sarebbe andata incontro ad un fallimento. Il suo indirizzo politico, che via via
maturò, si rivolse ad un socialismo vicino all’anarchismo proudhoniano.
Antiautoritario, in estrema sintesi egli fu uno dei precursori del
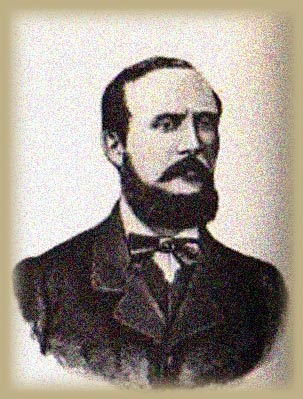 socialismo libertario.
socialismo libertario.
Nell’autunno del 1850 è a Genova dove
scrisse i suoi "Saggi storici-politici-militari
sull’Italia" (pubblicati postumi nel 1859).
Nel 1856 fondò il periodico "La parola
libera".
Si riavvicinò a Mazzini e, prendendo spunto
dai suoi suggerimenti, pianificò il progetto di
una spedizione nell’Italia meridionale.
Dopo un primo tentativo abortito, il
25 Giugno 1857 con altri 24 giovani (tra i
quali l’ufficiale calabrese Giovanni Nicotera),
si imbarcò sul piroscafo "Cagliari" (diretto a
Tunisi), la nave della compagnia Rubbattino
che, in alto mare, mise sotto il suo controllo.
In vista delle coste napoletane, non riuscì
ad incontrare la goletta che avrebbe dovuto
rifornire i rivoluzionari di armi.
Pisacane ed i suoi uomini sbarcarono il
27 Giugno sull’isola di Ponza, dove liberarono
328 detenuti (imprigionati quasi tutti per reati
comuni, solo 11 erano i prigionieri politici).
Di questi, Trecento lo seguirono nello
sbarco a Sapri, ma Napoli, che secondo il piano della spedizione nel Mezzogiorno avrebbe
dovuto insorgere grazie all’opera del Comitato napoletano, non si mosse.
Anzi, il governo borbonico, a conoscenza dell’impresa rivoluzionaria, mise in allarme tutte le
piazze militari e passo all’azione.
Il gruppo venne localizzato ed attaccato. Le truppe regie godettero inoltre dell’appoggio delle
masse contadine le quali, sobillate dal clero ed aizzate dalle autorità locali che sparsero la voce
di un imminente "sbarco di trecento ergastolani pronti a uccidere e saccheggiare",
aggredirono ferocemente gli uomini che, per ironia della sorte, erano venuti a "liberarli" dal
giogo tirannico-feudale dei Borboni. Il primo Luglio a Padula 25 rivoluzionari furono trucidati,
mentre alcuni scampati al massacro furono consegnati ai militari.
A Sanza nei pressi di Salerno furono ancora aggrediti dalla popolazione.
Perirono in 83.Carlo Pisacane, ferito, si uccise con un colpo di pistola.
Processati ( nel Gennaio 1858) e condannati a morte i superstiti vennero, in seguito, graziati
dal Re che tramutò la pena in ergastolo.
Garibaldi, dopo la liberazione del Mezzogiorno dai Borboni, con decreto dittatoriale, assegnerà
un
vitalizio di 60 ducati a Silvia (figlia di Carlo Pisacane). La stessa Silvia verrà adottata da
Giovanni Nicotera, che assolse così la promessa da lui fatta a fatta a Pisacane poco prima
del suo suicidio.
In ricordo di questo eroica ma disgraziata impresa, Luigi Mercantini compose l’ode celeberrima
dal titolo "La Spigolatrice di Sapri".
