
di quanto vale quando comincia a mancare.”
Piero Calamandrei
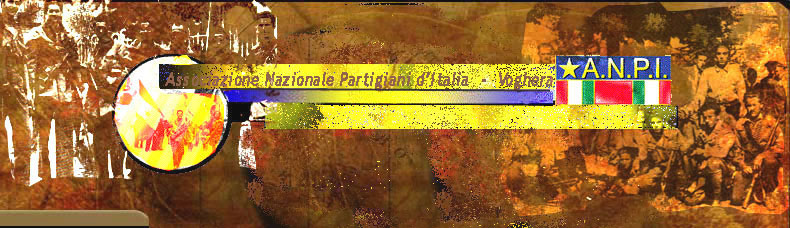
 L’ANPI Voghera commenta
L’ANPI Voghera commenta
Abbiamo voluto dedicare questa pagina web alle prese di posizione, ad eventuali polemiche verso fatti ed
episodi accaduti in città o nella nostra provincia.
L’obbiettivo è quello di sollecitare dibattiti, evidenziare avvenimenti e notizie, comunicare la nostra posizione sulla vita
sociale e culturale nazionale ed iriense.
- 25 Settembre 2012 -

Perché in tempi difficili va ritrovata la solidarietà

Se volgiamo lo sguardo verso altri tempi e altre culture, ci avvediamo senza particolare fatica di quanto intenso sia sempre stato il richiamo alla solidarietà, quale che fosse la parola adoperata per designarla. Per lungo tempo di essa si è parlato come appartenente all’ordine naturale delle cose, come di un dovere, come di uno «strumento di Dio, e governante degli uomini».
È quel che scrive nel ’500 Étienne de la Boètie, riferendosi esplicitamente alla natura: «bisogna pensare che distribuendo ad alcuni di più ad altri di meno, essa volesse dare spazio all’affetto fraterno e mettere gli uomini in grado di praticarlo, avendo gli uni capacità di offrire aiuto, gli altri bisogno di riceverlo». Nel secolo successivo John Locke dirà che «Dio non lascia un uomo alla mercé di un altro al punto che questi possa, volendo, farlo morire di fame (…) La carità dà diritto ad ogni uomo a quella parte della ricchezza di un altro che gli è necessaria per fuggire una situazione di estremo bisogno, quando non abbia altri mezzi di sussistenza».
Sono due soltanto tra gli infiniti esempi possibili, che ci parlano di una società “naturalmente” armonica. Ma questa idea morale si sarebbe sempre più mostrata incapace di reggere da sola il peso delle diseguaglianze, sì che poi si è scelta la strada che affidava all’artificialità del diritto, piuttosto che alla natura, i principi di libertà, eguaglianza, fraternità. Di questa triade rivoluzionaria proprio la fraternità si rivelò precocemente la componente più debole, tanto che Napoleone, nel suo proclama del 18 brumaio, si sarebbe presentato ai francesi come il difensore di “libertà, eguaglianza, proprietà”. La fraternità scompare, sopraffatta dal primato della proprietà, diritto a escludere gli altri dal godimento di un bene, dunque destinato a spezzare quel legame tra gli uomini che attraverso la fraternità si era voluto stabilire. Infatti, nel momento in cui la legislazione rivoluzionaria cancellava le appartenenze di ceto, tipiche del regime feudale, alla fraternità si affidava il compito di costruire la “nazione”.
Perché una condizione di minorità accompagna la fraternità oltre quel tempo, oltre la specifica vicenda francese? Una studiosa di storia, Mona Ozouf lo ha spiegato osservando che «tra la liberté e l’égalité da una parte e la fraternité dall’altra» non vi è «uno statuto equivalente. Le prime due sono dei diritti, la terza é un obbligo morale» (John Rawls ne ha parlato come di un “atteggiamento mentale”). Questa sbrigativa conclusione è stata poi ridimensionata dalla stessa Ozouf che, tornando sul tema, ha inteso «la fraternità meno come una comunione mistica e religiosa e piuttosto come quella esigenza di solidarietà senza la quale non hanno senso né la libertà, nè l’eguagianza». La prospettiva è completamente capovolta. Non solo la fraternità/solidarietà non ha uno statuto più debole, ma si pone addirittura come precondizione perché si possa attribuire significato a libertà e eguaglianza.
Lo slittamento semantico è rivelatore. Per recuperarne la forza, la fraternità è descritta come “solidarietà”. Due parole diverse si congiungono e, usate in molte occasioni come se fossero intercambiabili, accrescono l’ambiguità già rimproverata alla categoria della fraternità. Innescano anche un rifiuto culturale, soprattutto quando si teme che la solidarietà altro non sia che un travestimento di carità, beneficienza, compassione, tutte parole che non appartengono al lessico della dignità e dei diritti, ma rinviano piuttosto alla benevolenza altrui, sottolineando la minorità di chi si trova a esserne oggetto. Vicenda che sembrava lontana, confinata nei buoni costumi delle signore che si facevano “dame di carità”. Ma essa è tornata con il “conservatorismo compassionevole” che il Presidente Bush mise nel 2001 al centro del suo programma. “Compassion” ben presto sovrastata dal successivo e più aggressivo progetto di creazione di una “società della proprietà”, che faceva riemergere una storica opposizione.
Nella Costituzione italiana troviamo un altro tragitto, di cui si è voluta cogliere l’origine nella ricostruzione operata dal pensiero cattolico, e che è approdato alla formula che chiude l’articolo 2, dov’è scritto, subito dopo il riconoscimento dei diritti fondamentali che la Repubblica «richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Ma questa attribuzione al solo pensiero cattolico della solidarietà contrasta con la sua storia politica e culturale che, per gran parte dell’Ottocento, l’identifica piuttosto con l’internazionalismo operaio e con gli sforzi di ridimensionare la portata dell’individualismo liberale. È una vicenda che, scegliendo la parola “solidarietà”, laicizza il riferimento ad una fraternità che appariva troppo intrisa di religiosità. È una vicenda che si radica profondamente nel sentire socialista, tanto che nel 1936, durante la guerra civile spagnola, l’inno della brigata internazionale tedesca aveva come refrain “Viva la bandiera della solidarietà”. La solidarietà diventa così emblema e componente di una lotta politica, assume pure un significato conflittuale, e si allontana definitivamente da una appartenenza all’ordine naturale. Da qui prenderà le mosse una idea di solidarietà che, trovando significative consonanze con la riflessione cristiana, sarà alla base della costruzione dello Stato sociale. Da “obbligo della ricchezza” la solidarietà si fa dovere civico.
Nella Costituzione italiana questo segno è forte, congiunge diritti e doveri, individua il criterio in base al quale la persona si muove nella vita sociale. Non a caso la Corte costituzionale ha parlato della solidarietà come di uno dei «valori fondanti dell’ordinamento giuridico», di cui dunque deve tenersi conto nel definire la portata anche degli strumenti dell’agire privato come la stessa proprietà, il contratto, la responsabilità civile. E questo rinnovato insediarsi della solidarietà nel sistema costituzionale ha trovato conferma nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di cui è uno dei tratti innovativi e che descrive puntualmente l’insieme dei diritti che a essa fanno capo.
Ma i tragitti della solidarietà non sono lineari, conoscono fortune e rifiuti, momenti di eclisse, com’è tante volte accaduto in Europa negli ultimi due secoli, e che, nel 1976, inducevano Luciano Gallino a scrivere che il termine era “caduto pressoché in disuso nel lessico contemporaneo”. La solidarietà, comunque, riemerge sempre nel manifestarsi di una crisi. Non solo economica, ma anche politica, come ricorda la vicenda italiana della “solidarietà nazionale”. Dobbiamo concludere che essa è virtù dei tempi difficili e non un “sentimento repubblicano” che deve accompagnarci in ogni momento?
Vi sono rischi nell’intendere la solidarietà come un rimedio, e non come un principio.
Il primo è quello di chiudersi in comunità autoreferenziali, mentre il passaggio dalla fraternità alla solidarietà significava mettere la società al posto della comunità. Un altro riguarda l’abbandono della solidarietà “generale”, quella che lega le persone, permettendo ad esempio la garanzia pubblica della salute, e quella che lega le generazioni, che rende possibili i sistemi pensionistici. Infine, si rafforza la solidarietà “verticale” che produce piuttosto elargizioni, e non quella “orizzontale”, che intreccia agire pubblico e privato e mobilita la società.
Nel gran cantiere della solidarietà oggi l’attenzione non si concentra sullo Stato “protettore”, ma mette l’accento sui diritti sociali, come precondizione della stessa democrazia; si sposta, anzi, fuori del perimetro dello Stato, e dello Stato nazionale, per operare una redistribuzione sociale del potere e per rendere possibili forme di controllo dei poteri economici globali che evocano un nuovo internazionalismo; indica forme di gestione di beni della vita sottratti alle logiche proprietarie. Una solidarietà, allora, non costruita tutta all’esterno delle persone, ma che recupera forza e legittimità intorno all’ipotesi dell’uomo solidale”, non per natura, ma come effetto dell’azione politica e della riflessione culturale.
Stefano Rodotà
L’articolo di Stefano Rodotà - Perché in tempi difficili va ritrovata la solidarietà - è stato pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" il 25 Settembre 2012
