
di quanto vale quando comincia a mancare.”
Piero Calamandrei
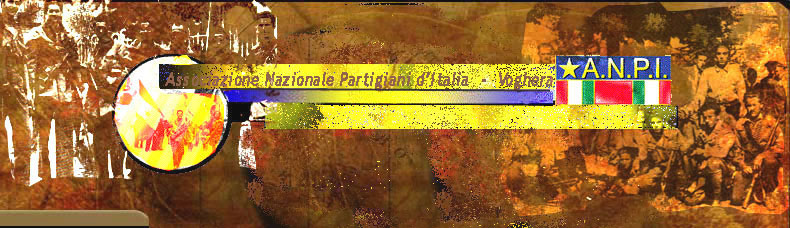
 Vittime italiane dello stalinismo
Vittime italiane dello stalinismo
Gli italiani vittime delle repressioni staliniane
L’emigrazione italiana si era formata in URSS in momenti ben distinti ed era, anche dal punto di
vista sociale, assai composita. Le origini più antiche erano quelle della comunità italiana di
Kerč’, formata per lo più da contadini pugliesi (ma anche liguri, veneti e piemontesi) che, a
partire dal XIX secolo, si erano a più riprese trasferiti sulle rive del Mar Nero in cerca di terre
fertili da coltivare e si erano stabiliti nella regione della Crimea, dove i loro discendenti vivono
ancora oggi.
Ma, a parte il singolare caso di Kerč’ e alcuni casi sporadici di artisti e lavoratori che si erano
stabiliti in Russia alla fine dell’Ottocento, la maggioranza degli italiani che ancora vivevano
in URSS alla metà degli anni Trenta era costituita da antifascisti trasferitisi a Mosca o nelle altre
città sovietiche dopo il 1922, spesso grazie all’aiuto della MOPR, nota in Italia come
"Soccorso Rosso".  A questa emigrazione cosiddetta "politica" si aggiunsero, dopo il 1929 e la
A questa emigrazione cosiddetta "politica" si aggiunsero, dopo il 1929 e la
grande crisi, anche coloro che lasciarono
l’Italia alla ricerca di un’occupazione e un
guadagno più sicuri: braccianti e artigiani,
marinai, talvolta ufficiali che abbandonavano
le navi italiane che facevano scalo nei porti
del Mar Nero. Ci furono anche maestranze
inviate dalle imprese italiane, come gli operai
specializzati e gli ingegneri che la RIV di Villar
Perosa mandò a Mosca nel 1932 per
costruire la "Prima fabbrica statale di cuscinetti
a sfera Lazar Kaganovič".
A partire dal 1933 le frontiere dell’Unione
Sovietica cominciarono a chiudersi, e il flusso
migratorio rallentò. Tra il 1932 e il 1936 Stalin impose il vincolo della cittadinanza sovietica
a tutti gli stranieri privi di regolare passaporto nazionale o riconosciuti come rifugiati politici.
Rifiutarla significava abbandonare tutto e venire rimpatriati, come accadde ad alcuni italiani di
Kerč’ e di Mariupol’, oppure cadere in odore di eresia; accettarla equivaleva ad affidarsi
completamente nelle mani delle autorità sovietiche, rinunciando per sempre all’ipotesi,
seppure remota, di un ritorno in patria.
Durante gli anni Trenta il "Terrore staliniano" colpì duramente le comunità straniere che
vivevano in Unione Sovietica e, fra queste, anche quella italiana conobbe l’esperienza della
persecuzione e della deportazione nei lager.
Sospettati, nella maggior parte dei casi, di attività antisovietica e di spionaggio, alcune centinaia
di italiani, per lo più emigrati politici giunti in URSS negli anni Venti, furono fucilati dopo
processi sommari o scontarono lunghe pene nei "campi di lavoro correzionale".
A questa vicenda di dolore e di morte si aggiunse, negli anni della seconda guerra mondiale,
la dura esperienza della deportazione in Kazachstan per la comunità italiana di Kerč’,
e l’arruolamento forzato nei battaglioni di lavoro per tutti gli italiani residenti in URSS.
 Nel 1956, dopo il XX Congresso del
Nel 1956, dopo il XX Congresso del
PCUS, anche gli italiani colpiti delle
repressioni staliniane furono
riabilitati.
Tra di essi molti erano ormai morti,
pochissimi erano stati liberati.
Ancor più rari furono i casi di coloro
che riuscirono a tornare in Italia.
Qui la memoria delle vittime italiane
del GULAG rimase a lungo taciuta,
complice l’ostinato silenzio del
Partito comunista italiano che
preferiva non ricordare le
responsabilità dei propri dirigenti e di
Togliatti, presenti a Mosca
negli anni Trenta.
Non meno dolorosa fu l’attesa del rimpatrio per chi ne fece richiesta: lunghi anni passarono
prima che qualche superstite potesse rientrare in Italia.
Dopo il 1992 però l’apertura degli archivi sovietici ha reso possibile la consultazione di una
ricca documentazione, che ha gettato nuova luce su origini, strumenti e obiettivi del
"Grande Terrore staliniano" . Sono così stati pubblicati, nel corso degli anni Novanta,
alcuni volumi, non solo in Italia ma anche in altri paesi d’Europa, volti alla ricostruzione delle
vicende che nella seconda metà degli anni Trenta avevano portato alla decimazione
delle comunità di diversa nazionalità, inclusa quella italiana, che vivevano in Unione Sovietica.
(tratto dal sito web http://www.gulag-italia.it)
All’interno del sito www.gulag-italia.it è possibile ripercorrere la storia dei Gulag, attraverso
la cronologia, approfondimenti, i profili di vittime e carnefici, mappe e informazioni sui lager.
Una parte specifica è: rivolta alla storia degli italiani nel Gulag.

