
di quanto vale quando comincia a mancare.”
Piero Calamandrei
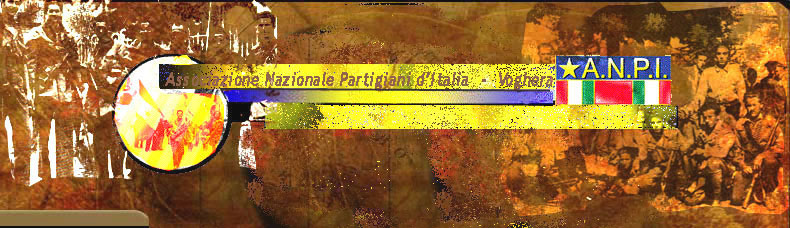
 Memoria in Campo
Memoria in Campo
di Giacomo Scotti ( articolo apparso sul quotidiano "Il Manifesto" in data 10 febbraio 2010 )
Ogni anno, dal 2004, il «Giorno del Ricordo» viene usato dalla retorica dei partiti della destra
italiana che affonda le sue radici nell’ideologia fascista, per cancellare le responsabilità italiane
e repubblichine nei massacri in terra slava e per ricordare foibe ed esodo dall’Istria e da
Zara in modo, dice Claudio Magris, «regressivo e profanatorio». E alla fine per riattizzare gli
odii nazionalistici antislavi all’origine dell’aggressione fascista del 1941.
Ogni anno, a cominciare dal 2004, celebrando il «Giorno del Ricordo» per ricordare la tragedia
delle foibe e dell’esodo, rischiamo inevitabilmente di guastare i buoni rapporti che
intercorrono fra i popoli delle due sponde adriatiche. Nel 2007 rischiammo addirittura una crisi
con la Croazia che, per fortuna, rientrò nel giro di una settimana. E poi nel 2008 con la
Slovenia. Temo però che, a causa delle ferite non rimarginate, il pericolo di rotture continuerà
a incombere, soprattutto se da parte italiana si dovesse continuare a ignorare la vera storia, se
si continuerà a coltivare una memoria parziale, che non tenga conto dei torti subiti dagli altri,
del dolore degli altri, delle tragedie altrui. Queste crisi ricorrenti, oltretutto, mettono in pericolo la
coesistenza, la convivenza e la tranquillità della minoranza italiana nel territorio
istro-quarnerino, di quei trentamila italiani rimasti in Croazia e Slovenia, che hanno saputo
tenacemente e pazientemente costruire, insieme ai conterranei croati e sloveni, una vita di
reciproco rispetto, di tolleranza, la convivenza nella multiculturalità.
Bisognerebbe però cambiare linguaggio e smetterla di guardare a croati e sloveni come a dei
barbari, come li chiamava Mussolini e come li definiscono i neofascisti che oggi scrivono sui muri di
Trieste «slavi di merda» e «slavi boia», pensando invece a mettere in mare nuove navi traghetto
accanto a quelle esistenti, di cui si servono italiani, croati e sloveni per transitare ogni giorno
dall’una all’altra sponda dell’Adriatico e del confine giuliano. In Istria e nel Quarnero, le cui
popolazioni hanno visto e subito nel secolo scorso tutte le violenze del fascismo e di altre
ideologie nazionalistiche, aggressioni e oppressioni, fino all’ esodo, si sa riconoscere il dolore
di tutti, dei rimasti e degli esodati, dei profughi di tutte le popolazioni.
Le recriminazioni e i rancori tipici di una destra dalle origini fasciste e missine, oggi sono fuori
della storia. Certo, la storia non si può cancellare e non va dimenticata ma ciascun popolo deve
saper fare i conti con la propria, senza sottacere o negare i buchi neri.
Esagerare, fino all’assurdo
Non si possono giustificare i crimini commessi in Istria tra il 10 settembre e il 4 ottobre 1943nell’insurrezione contadina seguita alla capitolazione dell’Italia, quei crimini che vanno sotto
il nome di foibe:
 ma nel ricordarli bisognerebbe sempre condannare anche i crimini e le
ma nel ricordarli bisognerebbe sempre condannare anche i crimini e le violenze dei fascisti: dall’una
e dall’altra parte dovrebbero
essere assunte le responsabilità
politiche delle rispettive pagine
nere del passato. Ognuno ha
diritto alla memoria, ma non ci
possono essere memorie
condivise se basate sulla
falsificazione e sul revisionismo
storico, e nessuno ha diritto di
usare il passato per attizzare
nuovi e vecchi rancori.
Sono fuori della storia e
rappresentano un’offesa terribile
non solo alla verità storica ma
anche alle popolazioni croate e
slovene certe truculente fiction
cinematografiche prodotte in Italia come «Il cuore nel pozzo» nelle quali in maniera manichea i
buoni e le vittime sono tutti italiani, mentre i malvagi e gli assassini sono tutti slavi.
A che scopo bollare come barbare intere popolazioni che pure soffersero l’oppressione,
la persecuzione, l’aggressione, l’occupazione degli italiani?
E perché poi certi avvenimenti storici dolorosi e tremendi come le foibe istriane vengono
presentati al di fuori del contesto storico delle «tormentate vicende del confine orientale», senza
una seria analisi storica, con l’enfatizzazione, l’esagerazione dei numeri fino all’assurdo?
Spesso, grazie a una libellistica di stampo ultranazionalistico viene elevata al rango di certezze
inconfutabili un’interpretazione della storia del confine orientale che è esclusivamente politica,
strumentale, centrata su una chiave nazionale e sulla mitologia nazionalistica, che non tiene
conto del male arrecato agli altri e, come dicevo all’inizio, del dolore degli altri.
La barbara razza slava
Quando parlo del dolore altrui, ovvero dei cosiddetti «barbari slavi» nostri vicini di casa nonalludo soltanto ai 20 anni di oppressione e repressione fascista subita dalle popolazioni croata
e slovena dei territori annessi all’Italia dopo la prima guerra mondiale, repressioni che portano
centinaia e migliaia di «allogeni» nelle carceri del Tribunale speciale, al confino ma anche
davanti ai plotoni di esecuzione, alla cancellazione della lingua e dei cognomi sloveni e
croati eccetera in tutto il territorio della Venezia Giulia e del Quarnero; non alludo soltanto ai
350.000 civili montenegrini, croati e sloveni massacrati, fucilati o bruciati vivi nelle loro
case durante i cosiddetti rastrellamenti delle nostre truppe che aggredirono l’ex Jugoslavia
nell’aprile 1941 occupando il Montenegro, la Dalmazia e parte della Slovenia annettendosi
larghe fette di quei territori; non alludo agli oltre centomila civili, compresi donne, vecchi e
bambini, che furono deportati e rinchiusi in oltre cento campi di internamento disseminati
dalle isole di Ugljan, Molat e Arbe in Dalmazia fino a Gonars nel Friuli ed alle migliaia di essi
che non rividero più la loro casa perché falciati dalla fame, dalle malattie e dai maltrattamenti
in quei «campi del Duce». Parlo soprattutto delle vendette fasciste, dei crimini compiuti dai
fascisti repubblichini italiani al servizio del tedeschi nei territori della Venezia Giulia e del
Quarnero dopo l’occupazione di quelle terre da parte della Wehrmacht, della loro annessione
al III Reich ovvero alla costituzione della Zona del Litorale Adriatico, dopo la prima decade di
ottobre del 1943 e fino alla fine di aprile del 1945.
Nella sola Istria i tedeschi, con la collaborazione della X Mas italiana, della cosiddetta
Milizia Difesa Territoriale italiana inquadrata nei reparti germanici e di altre formazioni militari o paramilitari, massacrarono oltre 5.000 civili, distrussero col fuoco alcune decine di villaggi,
deportarono 12.000 altri civili: e tutto ciò per «vendicarsi delle foibe», ovvero per
«sterminare la barbara razza slava».
 In realtà sterminarono italiani, croati e
In realtà sterminarono italiani, croati e sloveni senza distinzione, all’epoca tutti
cittadini italiani al di là dell’etnia. Ma oggi di
questo si preferisce non parlare. Invece
proprio a questa pagina orrenda
dimenticata, oggi vorrei tornare
per un attimo.
«Qui regna il terrore»
Il periodo che va dal 4 ottobre 1943al 30 aprile 1945, durante il quale l’Istria fu
«gestita» con le armi dai fascisti italiani e
dai tedeschi, fu un continuo susseguirsi
di stragi. In questi massacri, i fascisti repubblichini fecero da guida, da informatori/delatori,
ma furono pure quasi sempre esecutori. Tra i reparti italiani al servizio delle SS che si distinsero
nelle stragi ricordiamo il Reggimento «Istria» comandato da Libero Sauro, il reparto «Mazza
di Ferro» comandato dal capitano Graziano Udovisi (Udovicich) e l’unico reparto di
combattimento formato da sole donne, il Gruppo d’azione «Norma Cossetto» che alla sua
costituzione fu passato in rassegna a Trieste dal segretario generale del Partito Fascista Repubblicano Alessandro Pavolini, colui che, fucilato dai partigiani italiani il 28 aprile 1945, viene
oggi onorato a Rieti con una via intitolata al suo nome.
Vi risparmio la cronaca degli eccidi che indica da dieci a settanta vittime al giorno fino a
raggiungere le 300 del villaggio di Lipa (30 aprile 1944) con il cielo notturno quasi sempre
illuminato dalle fiamme degli incendi dei paesi. Mi limiterò ad alcuni documenti firmati dal
vescovo di Trieste, Antonio Santin, grande patriota italiano oriundo di Rovigno d’Istria.
Dopo aver denunciato mese dopo mese l’assassinio di vari sacerdoti istriani impiccati o fucilati
dai nazifascisti, il prelato così scrisse in una nota apparsa sul settimanale Vita Nuova
in data 18 aprile 1944: «Quello che avviene nell’Istria è spaventoso». «Le povere
popolazioni stanno pagando un terribile contributo di sangue e di distruzione delle loro
case. Lo spavento incombe su tutto e su tutti. Molti innocenti sono stati uccisi. Questo
dopo la prima invasione dei partigiani e il conseguente rastrellamento che avevano giù
prodotto rovine ingenti e un numero così elevato di morti. Noi assistiamo angosciati
a tanta rovina».
Cinque giorni dopo, il 23 aprile, Mons. Santin scrisse una lettera al comandante tedesco
Wolsegger. In essa si legge:
«In gran parte dell’Istria non vi è più traccia di vita civile. Regna il terrore».
«La popolazione dell’Istria è sottoposta a prove che hanno raggiunto il limite estremo
dell’umana sopportazione. In vastissime zone della provincia si conduce una vita da
allucinati».
La gente era costretta a vivere nei fienili, in grotte, in rifugi di fortuna, per non essere presi.
«Quando passano le formazioni SS allora avvengono le cose più atroci e più disonorevoli:
uccisioni di innocenti trovati a casa o sul lavoro, ruberie, distruzioni di case e di beni.
Cose indescrivibili e ignominose. La gente fugge terrorizzata».
Anche delle SS facevano parte, persino con funzioni di comando, fascisti italiani istriani come
Bradamante, Ravegnani, Niccolini ed altri. Ecco, anche questi fatti vanno ricordati. Come va
ricordato che molti dei civili massacrati in quel periodo dai nazisti e fascisti furono gettati nelle foibe.
Sdoganare la relazione condivisa
Vorrei concludere con lo sguardo volto a un futuro senza rancori. Per crearlo sarebbe beneaccettare la proposta della Slovenia di sdoganare la relazione condivisa ed approvata all’inizio
degli anni Duemila da una commissione paritetica di storici sloveni e italiani sul comune passato,
che sta chiusa da allora negli armadi del governo di Roma: accettare la proposta avanzata nel
2007 dal governo di Zagabria e finora rimasta senza risposta di rimettere in funzione la
commissione mista degli storici italiani e croati per scrivere una storia vera di quanto è avvenuto
sulla sponda orientale dell’Adriatico durante tutta la prima metà del Novecento; accettare
la proposta di una ricerca comune sui crimini perpetrati «prima, durante e dopo la seconda
guerra mondiale nell’ex Jugoslavia», appurando l’esatto o approssimativo numero delle
vittime italiane, croate, slovene e montenegrine. Serve infine un gesto solenne di
riconciliazione che faccia incontrare i presidenti dell’Italia, della Slovenia e della Croazia
per onorare le vittime delle foibe ma anche le vittime dei massacri compiuti dagli italiani.
La Slovenia e la Croazia, a livello governativo ma anche della stragrande maggioranza della
popolazione, hanno più volte ammesso e finalmente condannato le stragi delle foibe e la politica
jugoslava che nei primi 15 anni del dopoguerra portò all’esodo di 200.000 italiani e croati;
ma non si possono tollerare i discorsi razzisti antislavi pronunciati ogni anno in Italia
nel mese del «Giorno del Ricordo» da esponenti dell’estrema destra.
Le foibe ci sono state, l’esodo c’è stato, ma prima ci sono state le persecuzioni
italiane (fasciste) e l’aggressione fascista che portò all’annessione della cosiddetta Provincia
di Lubiana (Slo) di quasi metà Croazia, dell’intero Montenegro.
Resta il nostro dolore per le vittime delle foibe e per l’esodo. A livello politico Croazia e Slovenia
non giustificano più quei tristi fatti con i precedenti crimini del fascismo, perché non si giustifica
la vendetta. È però anche comprensibile il dolore dei figli e nipoti sloveni e croati i cui padri e
nonni furono vittime del terrore italiano in uniforme fascista o addirittura al servizio del nazismo.
È un dolore comprensibile anche quello; non si può negare a sloveni e croati di ricordare i loro morti, le sofferenze subite dai loro padri.
Bombardati come sono ogni anno di questi tempi da accuse di genocidio, molti croati e sloveni
ricordano a loro volta «la terribile occupazione italiana» delle loro terre, «le stragi compiute
dall’esercito fascista italiano» ed aspramente rimproverano quella parte dell’Italia che non
vuole ricordare i crimini italiani.
Purtroppo in troppi continuano a non rimuovere i buchi neri del loro passato.
La ferita oltre il confine
Bisogna ricordare tutto, contestualizzando la storia, senza dimenticare una parte e senzafalsificarla. In Croazia, Slovenia e Montenegro,
 dove vivono i figli e le figlie e i nipoti delle vittime
dove vivono i figli e le figlie e i nipoti delle vittime dell’occupazione italiana di quelle terre, del
duro regime instaurato ancor prima per venti
anni dal regime fascista in Istria ai danni dei
cosiddetti «barbari slavi», c’è
inevitabilmente chi si sente ferito dalla
retorica dei partiti e gruppi italiani che
affondano le loro radici nell’ideologia fascista
e che ricordano le foibe e l’esodo dall’Istria
e da Zara in modo «regressivo e
oggettivamente profanatorio» come
direbbe Claudio Magris, per riattizzare quegli
odii nazionalistici antislavi che furono all’origine
dell’aggressione fascista dell’aprile 1941
e della storia orrenda conclusasi con la
sconfitta dell’Italia nella seconda guerra
mondiale con la conseguente perdita dei
territori ottenuti dopo la guerra del Quindici-Diciotto. Una storia orrenda, ripeto, conclusasi
purtroppo anche con le foibe, con il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 e quindi con l’esodo
di gran parte delle popolazioni, dai territori definitivamente assegnati alla Jugoslavia; e gli
esuli, le grandi vittime, le vere vittime dell’avventura mussoliniana sulla sponda orientale
adriatica, non furono soltanto italiani, ma anche croati e sloveni. Sono tredici secoli che in quelle
terre si mescolano il sangue, le famiglie, i cognomi, le lingue e le culture.
Voglio ancora dire che il sangue dei vinti e dei vincitori, degli aggressori e degli aggrediti è
sempre sangue umano, e va rispettato, non strumentalizzato ai fini politici. Bisogna parlarne con
rispetto, senza l’ossessione e il rancore dell’offesa subita da chi vuole riconoscere il sangue
versato dagli altri e le offese subite dagli altri. Con i ricordi selezionati e unilaterali si perpetua
soltanto la catena delle violenze e delle vendette, si inocula nelle nuove generazioni l’odio
etnico. Dobbiamo invece ricordare tutte le vittime, di ogni parte, e contestualizzare storicamente
gli orrendi fatti che precedettero la seconda guerra mondiale, che caratterizzarono quella guerra
di aggressione fuori i confini d’Italia. Bisogna ricordare tutto questo, come direbbe il già citato
amico mio triestino Claudio Magris, «senza reticenze e senza strumentalizzazioni, senza
quell’orribile calcolo dei morti cui assistiamo in Italia ogni anno».
«Anche se i vostri morti fossero davvero quindicimila o ventimila, come qualcuno
afferma senza esibire documenti e nominativi - ha commentato un ex partigiano
croato - non si avvicinerebbero mai ai 350.000 jugoslavi massacrati».
Io dico: rispettiamo tutte le vittime. Come scrisse qualche anno fa il sindaco di Muggia
sul confine con la Slovenia, non vanno contrapposte foibe e guerra di liberazione
dal nazifascismo.
Nerio Nesladek, sindaco di quell’unico comune istriano rimasto in Italia, ritiene giustamente che
«rifiutare il dialogo e continuare con le contrapposizioni - come fanno i circoli
ultranazionalisti italiani di Trieste, non ci porterà da nessuna parte. Dobbiamo andare
oltre le divisioni e i rancori e guardare avanti». Ben detto, io questo volevo dire.



